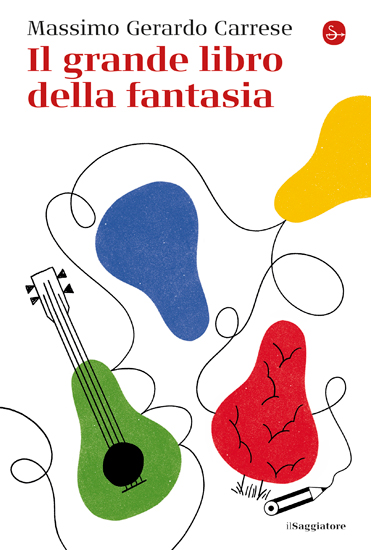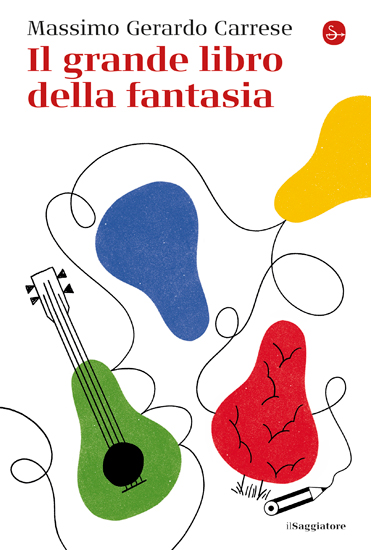 Il grande libro della fantasia
Il grande libro della fantasia (il Saggiatore, 2023)
LINK LIBRO
Il grande libro della fantasia di Massimo Gerardo Carrese è un saggio di fantasiologia.
Rappresenta un esercizio finora irrealizzato: fare dei processi
creativi una storia da raccontare e una scienza da applicare. Dai
Dialoghi di Platone alle opere di Bruno Munari, fino alle sfide
dell’intelligenza artificiale, una materia incontenibile come la
fantasia si dispiega cominciando con lo studio dei primi sguardi sul
mondo e terminando con le tecnologie che annullano i confini tra
realtà e finzione. Si rivela così un gioco lungo millenni
le cui regole restano perlopiù misteriose.
Carrese ci permette di scoprire, inoltre, i segreti e le differenze che
intercorrono tra fantasia, immaginazione e creatività: i
processi biologici e psicologici che le coinvolgono, le diverse
capacità combinatorie che la nostra mente applica di volta in
volta, i risultati – sempre straordinari e inediti – a cui
l’umanità è approdata facendone un uso
quotidiano.
Ad accompagnare i capitoli, sezioni ludiche ci aiutano a trasferire la
riflessione «fantasiologica» dal piano teorico al piano
pratico: e allora tutto diventa possibile, un telecomando può
trasformarsi in una sedia, una palla da basket in un'automobile.
Perché non esiste alcun limite alla possibilità di
reinventare l’universo in cui viviamo.

Massimo Gerardo Carrese, 2023
che cos'è la fantasiologia?
«La
parola φαντασία (phantasia) è
legata a φαίνω (phàinō) che vuol dire
"mostrare", "rendere manifesto", "sembrare", "apparire", "rivelare". La
φαντασία ausculta
possibilità, cioè opportunità da svelare, quando
mette in relazione, in certi modi, le cose del mondo e le nostre
conoscenze. Lavora con le possibilità essenzialmente in tre
maniere, suggerite dai significati richiamati poc’anzi: per apparizione, quando le riflessioni, per esempio una metafora su un battello a vapore, trovano spazio solo nella nostra testa; per sembianza, quando facciamo finta che una penna sia un battello a vapore e la animiamo; per dimostrazione, quando siamo in grado di provare, secondo una logica oggettiva, che quella stessa penna sia anche un battello a vapore.
"Anche" è possibilità, relazione, congiunzione.
La φαντασία, da apprendere insieme all’εἰκασία (eikasia:
immaginazione), si muove in vasti campi e contesti storici, databili
dal V secolo p.e.v., per cui non disponiamo di una sola sua
definizione. Questo ci rende le cose complicate e al tempo affascinanti
perché possiamo analizzarla da più punti di vista.
La fantasiologia che
studiamo dal 2001, individua i processi scientifici e umanistici,
ludici e artistici che qualificano la
φαντασία, affinché sia
esercizio di disvelamento e apertura a nuove possibilità di fare
relazione.»
Massimo Gerardo Carrese, Una nota sulla φαντασία, Manifesto "Per Disvelare" 04/03/2023

Massimo Gerardo Carrese, 2021
Massimo Gerardo
Carrese, fantasiologo di professione, nelle sue opere definisce la fantasiologia come studio critico e analitico degli aspetti
scientifici, umanistici, ludici e artistici della fantasia (il possibile),
dell'immaginazione (le immagini mentali) e della creatività (la tecnica e
l’originalità).
Fantasia-immaginazione-creatività sono le tre parole essenziali
della fantasiologia ma per comprenderle a fondo è necessario studiare la percezione,
l’associazione, la fantasticheria, la realtà.